

 È incredibile come la lettura stimoli la mente. Siccome sono pigro tendo a perdere tempo guardando video su YouTube: alcuni di questi sono anche molto informativi ma è chiaro che il cervello che ascolta non è altrettanto attivo di un cervello che legge. Poi, certo, sarà importante anche il contenuto degli specifici video o libri…
È incredibile come la lettura stimoli la mente. Siccome sono pigro tendo a perdere tempo guardando video su YouTube: alcuni di questi sono anche molto informativi ma è chiaro che il cervello che ascolta non è altrettanto attivo di un cervello che legge. Poi, certo, sarà importante anche il contenuto degli specifici video o libri…Comunque ieri, dopo qualche giorno di languore mentale, sono riuscito a leggere un’oretta in giardino: quando ho finito avevo la testa che mi scoppiava di idee e di ragionamenti!
Se non erro ero partito leggendo Gandhi, poi ero passato a Marco Aurelio, poi a Hobsbawm e, finalmente, avevo optato per Rawls. La sera, a letto, invece leggo un libro di fantascienza leggero (“Gladiatore in legge”) e “Pensieri” di Pascal. Lo specifico perché poi emergerà un collegamento…
In realtà avrei da scrivere su uno qualsiasi dei libri che sto leggendo però, per motivi di tempo, devo fare una scelta. Opto per Hobsbawm perché mi permette di accennare ad altri libri.
Il capitolo de “L’età degli imperi” che sto leggendo è sulla scienza.
In particolare mette in evidenza la crisi delle certezze che ci fu a cavallo fra il XIX e XX secolo sia in matematica che in fisica. La questione matematica rimase di più nel mondo accademico e quindi è di minore interesse per lo storico che invece è interessato agli eventuali effetti sulla popolazione.
Nella fisica invece si hanno due rivoluzioni: una nell’infinitamente grande, nel passaggio da una visione di un universo newtoniano a uno relativistico; e nell’infinitamente piccolo con la fisica quantistica di Planck. In entrambi i casi vi è un contrasto fra scienza e intuizione: cioè la scienza va contro l’intuizione e questo toglie, in generale, molte sicurezze. La matematica diventa sempre più astratta e, apparentemente, fine a se stessa (*1).
A inizio XX secolo vi è poi la separazione fra le scienze naturali e quelle sociali. A questo proposito posso citare un altro libro che sto leggendo: “Psicologia criminale” di Longo. Scaricato da progetto Gutenberg si tratta di un libretto piuttosto noioso in cui un avvocato cerca di misurare, bilanciare e spiegare in maniera quasi matematica come la psicologia dei criminali sia diversa dal normale. Evidentemente tale libro (mi sembra del 1910) cerca di stare dietro con il suo meccanicismo alle scienze naturali: tutto è misurabile, le reazioni umane sono frutto di funzioni e variabili, a soglie che se si superano provocano precise reazioni. A leggerlo adesso suona assurdo ma fa capire l’epoca, come tutto, compresa la psicologia umana, fosse circoscrivibile in precise formule. Si comprende bene quindi la nascita dell’olismo in reazione a queste sicurezze: il tutto è maggiore della somma delle singole parti, un concetto che rompe la logica del meccanicismo. Vabbè sto divagando.
Come esempio concreto del travaglio della fisica Hobsbawm presenta la parabola dell’etere: una sostanza che a inizio XX secolo si riteneva riempisse lo spazio e che fosse necessaria, per esempio, per la propagazione delle onde elettromagnetiche.
Concetto che non mi è nuovo perché mio padre, un fisico, decine di anni fa fu molto divertito da un vecchio libro di fisica degli anni ‘20 in cui l’esistenza dell’etere non era messa in dubbio ma data per verità scientifica!
Curiosamente, se ben ricordo (non posso verificare perché non ho il relativo libro con me), anche il libro “Râja Yoga”, scritto a inizio XX secolo, accenna all’etere. Se non erro, lo yogi autore del libro lo introduce per spiegare la connessione fra l’uomo e il tutto e, anzi, lo prende a esempio di come la scienza occidentale riscopre quanto già noto alla saggezza orientale. Ma vado a memoria: è roba che ho letto mesi fa (*2).
Hobsbawm sottolinea poi come abbandonare il concetto dell’etere per sostituirlo con quello del vuoto assoluto fosse difficile anche per gli scienziati. Scrive Hobsbawm: “Insomma, ciò che rese la rivoluzione della fisica tanto rivoluzionaria non fu la scoperta di fatti nuovi, che pure non mancò, ma la riluttanza dei fisici a rivedere i loro paradigmi.”
Non era tanto un problema di accettare nuove idee quanto di abbandonare vecchie convinzioni: psicologicamente comprensibile: mentre è relativamente facile aggiungere all’esistente, togliere un qualcosa di essenziale costringe a ricostruire (rivalutare) tutto ciò che su esso si basava. Figuriamoci poi se questo elemento era alla base della loro comprensione del mondo e della realtà!
Curiosamente qualche giorno prima avevo letto un passaggio di Pascal con forti similitudini e attinenze alla rivoluzione della fisica descritta da Hobsbwam.
Il riferimento all’infinitamente grande e infinitamente piccolo si trova in un “pensiero” particolarmente lungo e articolato da cui è difficile estrarne delle frasi che riassumano l’idea in poche parole. Pascal vuole evidenziare la difficoltà dell’uomo, nel suo percorso di conoscenza, a confrontarsi con cose enormemente più grandi di lui ma anche in quelle molto più piccole (il pensiero è intitolato “Sproporzione dell’uomo”). L’uomo è inadeguato a comprenderle pienamente: deve accontentarsi di semplificazioni (insomma il mio concetto dei protomiti! [E] 2.2, “Il protomito”).
Limitatezza dell’uomo: “Tutto il mondo visibile non è che un tratto impercettibile nell’ampio seno della natura. Nessuna idea vi si avvicina; abbiamo un bel dilatare le nostre concezioni al di là degli spazi immaginabili, non partoriremo che degli atomi, in confronto alla realtà delle cose. È una sfera infinita il cui centro è ovunque, la circonferenza in nessun luogo.” (*3)
Sull’infinitamente grande: “Che [l’uomo] guardi quella luce splendente posta come una lampada eterna a illuminare l’universo, che la terra gli appaia come un punto in confronto al vasto giro che quell’astro descrive, e si stupisca del fatto che questo vasto giro è esso stesso solo un fragile frammento rispetto a quello descritto dagli astri che ruotano nel firmamento.” (*3)
E sul piccolo: “Ma per presentargli [all’uomo] un altro prodigio altrettanto stupefacente, cerchi fra ciò che conosce le cose più minute […]
Voglio fargli vedere lì dentro un nuovo abisso. Voglio dipingerli non soltanto l’universo visibile, ma l’immensità della natura che si può concepire nello spazio limitato di quello scorcio d’atomo; che vi scorga un’infinità di universi, di cui ciascuno ha il suo firmamento, i suoi pianeti, la sua terra […]” (*4)
Riassumendo: “Di questi due infiniti delle scienze, quello di grandezza è molto più percettibile, e perciò è capitato a poche persone di pretendere di conoscere ogni cosa. […]
Ma l’infinità nella piccolezza è molto meno evidente. I filosofi hanno spesso preteso di arrivarci, ed è qui che tutti si sono impigliati.” (*5)
Insomma Pascal, che scrive nel XVII secolo, avverte di quanto ciò che è fuori scala con l’uomo sia inerentemente difficile da comprendere pienamente. Nel XVIII-XIX secolo gli scienziati pensano di aver capito tutto, o almeno l’intelaiatura generale della realtà, ma all’inizio del XX secolo si scopre che nell’infinitamente grande e piccolo la scienza è da riscrivere! Insomma l’intuizione di Pascal si è dimostrata corretta e ha anticipato l’errore di arroganza della scienza nei secoli immediatamente successivi al suo: notevole!
Mi sembrava che Pascal citasse direttamente l’etere ma forse ero solo stato io ad associare tale concetto alle sue parole. Comunque ecco qui: “‘Poiché – si dice – avete creduto fin dall’infanzia che un baule fosse vuoto quando non ci vedevate dentro niente, avete creduto possibile il vuoto. È un’illusione dei vostri sensi , rafforzata dall’abitudine, che la scienza deve correggere’. E gli altri dicono: ‘Poiché vi hanno detto a scuola che il vuoto non esiste, si è corrotto il vostro senso comune che lo comprendeva con tanta chiarezza, prima di questa impressione sbagliata, che bisogna correggere ricorrendo alla vostra natura originaria’. Chi ha ingannato dunque, i sensi o l’istruzione?” (*6)
Insomma è l’etere o il vuoto che esiste? In realtà Pascal accenna appena al problema: il suo scopo è solo quello di spiegare come l’uomo sia plasmabile nell’infanzia e di come le prime impressioni siano durature. In effetti intuizioni psicologiche più che corrette.
Al di là del linguaggio un po’ troppo fiorito per i miei gusti, ma probabilmente era lo stile del tempo, le intuizioni di Pascal sono notevoli: ho già scritto di come in molti pensieri attribuisca le azioni dell’uomo alla sua “concupiscenza” e di come io ne ero rimasto perplesso fino a quando non mi sono reso conto che se sostituivo a “concupiscenza” la “libido” di Jung tornava tutto?
Conclusione: il solito sito inaffidabile a cui mi affido sempre dà Pascal come INTP: ancora io non mi sbilancio ma mi pare plausibile...
Nota (*1): ma oggi sappiamo che spesso le nuove tecnologie vanno a rispolverare oggetti matematici, scoperti e studiati decine e decine di anni prima, che solo adesso trovano delle applicazioni pratiche…
Insomma il non avere relazioni col concreto è anche relativo all’epoca e non una proprietà assoluta della matematica.
Nota (*2): infatti tale libro non mi piace: è il seguito di un’altra opera dello stesso autore che non ho e che illustra i concetti base applicati poi in questo libro. Non l’ho dimenticato da mio padre ma proprio non me lo sono volutamente portato dietro per non appesantirmi la borsa!
Nota (*3): tratto da”Pensieri” di Blaise Pascal, (E.) Orsa Maggiore Editrice, 1995, trad. Chiara Vozza, pag. 75.
Nota (*4): ibidem pag. 76.
Nota (*5): ibidem pag. 78.
Nota (*6): ibidem pag. 68.
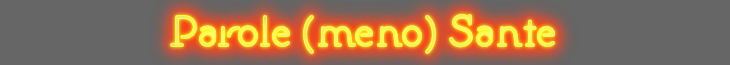











Nessun commento:
Posta un commento