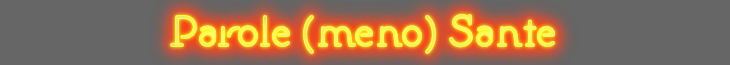Ci pensavo da qualche giorno: quando è che l’ignoranza diviene colpevole?
Ci pensavo da qualche giorno: quando è che l’ignoranza diviene colpevole?Per la legge sempre, o almeno da quando qualcosa è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma io sono più tollerante. La vita umana è limitata e questo ha ripercussioni sulla conoscenza e il tempo che si può dedicare a essa.
Poi, ovviamente, non intendo la conoscenza dello scibile, di ciò che si trova sui libri e che viene insegnato nelle università.
Ho in mente qualcosa di più semplice: la conoscenza di ciò che succede nel mondo intorno a noi: la guerra a Gaza, quella in Ucraina, la pandemia…
Non una conoscenza profonda ma su grandi linee che però dia un’idea fattuale delle ragioni dietro ciò che accada: un po’ più in là dei semplici fatti ma non tantissimo.
In teoria questa conoscenza dovrebbero darcela i media tradizionali: telegiornali, quotidiani e magari trasmissioni di approfondimento giornalistico. Come sapete però siamo in una fase di decadenza politica, sociale, culturale ed economica (v. [E] 15, “Decadenza”) e i media fanno il contrario di ciò che dovrebbero: non informare ma disinformare. Sui motivi e interessi di questo comportamento non starò a ripetermi: l’ho già scritto e nel contesto di questo pezzo non è importante.
Il mio quesito iniziale diviene quindi equivalente a: fino a quando la fiducia nei media non è colpevole?
Come detto io sono, mi pare, molto tollerante: sono ben consapevole, ormai anche di questo ho scritto più volte, che all’origine di questa fiducia non vi è la razionalità ma delle specifiche psicologie con cui si nasce e che, senza particolari esperienze personali, sono molto difficili da superare (*1).
Anche qui è inutile che mi ripeta ma le categorie di persone che tendono a fidarsi dei media sono i **TJ, che confidano nell’ordine dell’autorità costituita di cui i media sono la voce, e gli **FJ particolarmente influenzabili da quello che è percepito essere il pensiero comune. A una prima approssimazione parliamo del 50% della popolazione poi, siccome gli ISTJ e gli ESFJ sono fra i tipi più comuni, si arriverà anche al 60%, non so (*2)…
Insomma sono tollerante perché chi crede nei media è spesso in buona fede: magari ogni tanto si accorge che qualcosa non quadra ma, a causa della propria natura, preferisce ignorare questi dubbi prima che si accumulino e lo costringano a una riflessione più approfondita che potrebbe portare a una revisione della propria posizione che pochi hanno la volontà e la forza di compiere spontaneamente (limite dell’anti-resipiscenza, v. [E] 1.1, “Il limite cognitivo”).
Ma, insomma, quando è che l’ignoranza, cioè la fiducia nei media, diviene colpevole?
La fiducia diviene colpevole quando le bugie divengono evidenti: a quel punto, quando ci si rende conto che i media hanno volutamente e scientemente diffuso falsità che sapevano essere tali, è doveroso iniziare a nutrire grossi dubbi su qualunque informazione riportata da essi.
Ma le bugie sono evidenti? Beh, il punto è proprio questo: se ci si affida ai soli media allora i loro inganni ancora non sono palmari. Sarebbe più facile capirlo confrontando le informazioni dei media tradizionali con quelle dell’informazione indipendente: i primi di solito si limitano ad asserzioni, “le cose stanno così perché lo dice l’autorità (scientifica, politica o economica)” mentre i secondi forniscono delle motivazioni che poi è facile generalizzare e verificare che abbiano senso. Ma l’informazione indipendente va ricercata attivamente dato che non ha la forza di raggiungerci autonomamente: questo sforzo non tutti sono disposti a compierlo (limite misconoscenza, v. [E] 1.1, “Il limite cognitivo”).
Ingenuamente già nell’autunno-inverno 2021 pensai che, osservando la marea crescente di ricerche scientifiche che dimostravano che i vaccini mRNA non erano né sicuri né efficaci, la verità sarebbe dovuta venire a galla nel giro di massimo pochi anni rendendo evidenti le bugie propalate, spesso ma non sempre in malafede, dai media. Avevo sottovalutato che la politica ci aveva messo la faccia e che soprattutto l’opposizione aveva fatto lo stesso e, quindi, non poteva sfruttare la verità scientifica emergente per avvantaggiarsene politicamente.
Notevole per esempio come oggi si taccia sulla mortalità in eccesso che colpisce molti paesi occidentali: dopo una pandemia in cui muoiono le persone più deboli dovrebbe essere in difetto!
Sulla pandemia continuo quindi a essere tollerante verso chi è ancora convinto che i provvedimenti sanitari applicati furono corretti e giustificati.
Il problema di fondo è che la voce della scienza è fioca e, se i media non la amplificano, la gente comune non riesce a udirla.
La guerra fra Ucraina e Russia è invece uno scenario completamente diverso: le verità militari, soprattutto nell’aspetto più evidente di conquiste territoriali, sono molto più difficili da tacere.
Anche su questa guerra, forse ancor più che con la pandemia, i media tradizionali si sono schierati all’unisono, come un coro ben affiatato, a ripetere le “verità”, ovvero la propaganda di Washington.
Alcuni topoi sono (non menzionando le vere e proprie bufale periodicamente affermate dai servizi segreti inglesi):
1- Putin è pazzo e vuole conquistare il mondo o almeno l’Europa.
2- L’attacco della Russia è stato non provocato e ingiustificato.
3- Le sanzioni economiche piegheranno la Russia in pochi mesi.
4- L’Ucraina sta vincendo e riconquisterà non solo i territori occupati dai russi nel 2022 ma anche la Crimea.
Potrei continuare ma non voglio ripetermi e, comunque, gli esempi qui sopra sono già significativi.
I punti 1 e 2 chiaramente non sono facilmente dimostrabili falsi: cioè ci sarebbero i filmati con le dichiarazioni di Putin sugli obbiettivi della SMO, oppure ci sarebbero le interviste della Merkel e Holland sugli accordi di Minsk, ci sarebbero otto anni di vittime nelle regioni separatiste dal 2014 al 2022… ma, insomma, manca quell’evidenza innegabile che anche i nostri media non potrebbero tacere…
Sull’utilità ed efficacia delle sanzioni invece iniziano a emergere dei dati economici incontestabili: l’economia russa va bene, anzi benissimo, quella europea cola a picco. Oppure guardate l’inflazione…
Ma anche la voce dell’economia non è così chiara: i grafici possono esser nascosti o magari mostrati per un solo attimo. Qui il problema è che, per la gente comune, l’economia è un misto di matematica e astrologia che rimane esoterico ai non iniziati. L’esperto di turno ha facile gioco a “spiegare” che il “+” è “-” e viceversa o che il prossimo anno (sempre il prossimo) la Russia fallirà e l’Europa sarà ricchissima, la popolazione lavorerà un giorno in meno e guadagnerà come se lavorasse un giorno in più etc.
Ma la sconfitta dell’Ucraina non sarà mascherabile, soprattutto se Kiev sarà costretta a pesanti concessioni territoriali. Ovviamente i media cercheranno di ribaltare la frittata: per esempio che l’occidente ha vinto perché Putin non è riuscito a conquistare l’Europa ma solo qualche pezzetto di Ucraina. I media statunitensi già da un paio di mesi avevano poi iniziato ad abbassare le aspettative sul successo ucraino e quelli europei hanno iniziato a obbedire alle nuove direttive da un mesetto.
Ma in questo caso mi aspetto un minimo di memoria da parte dei **TJ (che in realtà, soprattutto gli ISTJ, dovrebbero averla) e dei **FJ.
Mi aspetto che queste fasce di popolazione si rendano conto di essere state ingannate: che l’Ucraina non stava vincendo ma perdendo. E se questo è falso allora dovrebbero riflettere sulle motivazioni di questa falsità. Dovrebbero capire che è stato l’occidente a volere questa guerra sanguinosa e totalmente inutile: che gli USA speravano di guadagnarci e che l’Europa aveva tutto da rimetterci. Che i politici che ci guidano sono quindi impreparati e incoscienti.
E se i media hanno mentito sulla guerra in Ucraina allora mi aspetto anche una rivalutazione obiettiva di quanto affermavano durante la pandemia tenendo stavolta la mente ben aperta alla possibilità che mentissero anche all’epoca.
Mi aspetto poi che tutti diventino più cauti nel credere in qualsiasi affermazione faranno i media in futuro, tenendo ben a mente che potrebbe trattarsi di una bugia bella e buona…
Ma… temo che le mie aspettative siano un po’ troppo alte!
Innanzi tutto vediamo come evolve la guerra in Ucraina e come i media ne dipingeranno la sconfitta. Quando? Bella domanda!
Per previsioni attendibili occorrerebbero informazioni accurate che non abbiamo: io CREDO da 3 a 6 mesi ma un crollo improvviso dell’esercito ucraino non mi sorprenderebbe e questo potrebbe avvenire anche domani senza preavviso o quasi.
Conclusione: realisticamente non tutti i **TJ ed **FJ cambierebbero idea ma anche se solo una fetta significativa di questi aprisse gli occhi allora la maggioranza della popolazione potrebbe divenire quella composta da persone che si rendono conto di venir prese in giro con risultati imprevedibili (*3).
Nota (*1): ovviamente è possibile vincere la propria natura ma ci vuole uno sforzo maggiore. Un bellissimo esempio è quello del Dr. Campbell, probabilmente un ESTJ (ma io sospetto un ISTJ), che nel giro di circa due anni, basandosi sui fatti, sulle ricerche cioè, ha ribaltato la propria posizione sui vaccini sperimentali mRNA.
Nota (*2): questa stima si potrebbe ulteriormente raffinare considerando l’età e il fatto che la degenerazione dei media si è verificata progressivamente; si potrebbero poi considerare le persone che vanno dietro alla maggioranza senza avere delle forti opinioni e che, proprio per questo, sono pronte a cambiare il proprio punto di vista appena lo fa la maggioranza…
Nota (*3): proprio chi si rende conto che, fidandosi, era stato ingannato sarà fra i più arrabbiati. L’ho notato nei pentastellati, magari ex attivisti, che si sono resi conto che il M5S aveva tradito la loro fiducia.