

 Ho finito di leggere “Un mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo” di Huxley. Siamo di fronte a un 5 stelle. Diciamo che il romanzo è forse da tre o quattro stelle ma il saggio è sicuramente da cinque e si trascina dietro anche il precedente.
Ho finito di leggere “Un mondo nuovo – Ritorno al mondo nuovo” di Huxley. Siamo di fronte a un 5 stelle. Diciamo che il romanzo è forse da tre o quattro stelle ma il saggio è sicuramente da cinque e si trascina dietro anche il precedente.Un libro che consiglio a tutti nell’edizione Mondadori che abbina romanzo e saggio insieme: vanno letti entrambi, prima il romanzo e poi il saggio.
In realtà è un libro che andrebbe letto con (beh, prima o dopo, non ha importanza!) “1984” di Orwell. La distopia orwelliana è giustamente famosa e, qua e là, soprattutto nella sorveglianza tecnologica vi riconosciamo degli aspetti del mondo moderno.
Ma complessivamente ci rendiamo altrettanto conto che l’orrore di “1984” non si è realizzato nell’occidente e, probabilmente, neppure nella vecchia URSS. È un mondo che ci fa paura, perché come detto le similitudini con la nostra realtà ci sono, ma complessivamente ci rassicuriamo constatando che non mostra la nostra quotidianità.
Invece è l’opera di Huxley che completa il quadro.
Anche “Il mondo nuovo” considerato a sé stante manca il bersaglio: nemmeno la sua distopia si è realizzata.
Se però mettiamo insieme “1984” a “Un mondo nuovo” ecco che abbiamo la società occidentale del 2024: ovviamente bisogna avere la fantasia di riuscire a riconoscere gli elementi dei due romanzi che vadano mescolati insieme. Probabilmente, almeno a livello di proporzioni, siamo a ¼ di Orwell e ¾ di Huxley con la tendenza però al crescere del primo autore.
Gli ultimi sottocapitoli li ho letti in pochi giorni. Il penultimo è intitolato “Educazione alla libertà”. Il concetto non mi è nuovo, curiosamente lo ventilò proprio Anonimo mesi fa e da allora mi era rimasto a prudermi in testa.
Sfortunatamente questo sottocapitolo delude un po’ le aspettative: tutta la prima parte vuole dimostrare l’importanza della libertà per l’uomo che non è un animale completamente sociale ma ha invece una spiccata individualità: se si opprime questa individualità si attacca la sua umanità.
Tutto sommato un argomento che ricorda la mia obiezione più profonda a Rawls: costringendo tutti gli uomini sullo stesso livello se ne cancella l’umanità che invece si vorrebbe tutelare e proteggere.
“Constatazione dei fatti ed enunciazione dei valori” è la ricetta di Huxley.
Alla fine la “constatazione dei fatti” si riduce a un’educazione che, fin dalla scuola, insegni ai giovani studenti a riconoscere la propaganda come tale. In realtà già negli anni ‘30 era stato studiato un programma di questo genere grazie all’impegno di un generoso filantropo ma nel 1941 l’idea fu abbandonata: gli USA avevano infatti iniziato a usare massicciamente la propaganda nello sforzo bellico.
L’“enunciazione dei valori” invece servirebbe come filtro, come criterio per capire quando la popolazione ha il dovere di reagire: un confine estremo che il potere non deve avere il diritto di superare. Nello specifico si tratta del valore dell’individualità all’interno di un’unica razza da cui poi dovrebbero derivare tolleranza e carità (aiuto reciproco, collaborazione).
Questi sono i valori-limite che il potere non deve superare: non importa quali siano le sue giustificazioni speciose e le emozioni (prima la paura) su cui faranno leva.
In realtà si tratta di un capitolo di 10 pagine che avevo riempito di note di cui mi ero ripromesso di scrivere più approfonditamente (oltretutto con un paio di epigrafi) ma ora invece preferisco limitarmi all’essenza.
In verità c’è qualcosa che non mi soddisfa in questa intuizione di Huxley: niente di sbagliato ma piuttosto di incompleto. Ecco, ho la sensazione che abbia dimenticato qualcosa di importante però non riesco ancora a puntare il dito su niente di specifico.
Diciamo che ho la sensazione che l’educazione non basti: non si tratta di concetti che vanno semplicemente saputi ma devono anche essere profondamente compresi per essere apprezzati pienamente. In un pezzo intitolato “Puericoltura base” (mi pare: non ho voglia di controllare...) spiegai che forse il compito più importante della scuola dovrebbe essere quello di insegnare la responsabilità e, avendo io una natura pratica, suggerivo anche delle idee su come fare.
Ecco con la libertà si dovrebbe fare qualcosa di analogo: per esempio si potrebbe dividere la classe in due parti, diciamo ¼ e ¾ (è importante che la parte più piccola non sia rappresentativa del tutto) magari scegliendo gli studenti più bravi in una specifica materia scelta a caso. Poi a questa minoranza e solo a questa minoranza verrà data la possibilità di scegliere degli specifici compiti per casa o un libro da leggere mentre gli altri studenti potranno solo ascoltare in silenzio. E così, per un semestre o un trimestre, gli stessi studenti decideranno per il resto della classe: questo dovrebbe aiutare a far comprendere a tutti la reale importanza della libertà.
Oltretutto i concetti di libertà e responsabilità hanno delle significative sovrapposizioni.
Non erroneamente ma in maniera incompleta si educa i bambini a riconoscere e denunciare i soprusi che subiscono dai loro pari. Questo è giusto e va fatto. Andrebbe però anche sottolineato che il maggiore pericolo per la libertà non viene dai nostri simili ma dal potere costituito. Il singolo individuo può attentare alla libertà di altri singoli individui ma è l’autorità che può appropriarsi della libertà di tutti. Agli studenti dovrebbe quindi essere insegnato che l’obbedienza al potere deve avere dei limiti: che ci sono dei confini, come afferma anche Huxley, che non possono essere oltrepassati.
Lo stato insomma dovrebbe inserire nei programmi scolastici l’insegnamento alla disubbidienza verso se stesso: e infatti non lo fa…
Conclusione: l’educazione alla libertà è qualcosa di fondamentale che non è facile insegnare. E di sicuro ormai la questione se lo Stato là inserirà mai nei programmi scolastici è un qualcosa di superato: come ho scritto altrove lo scopo della scuola è ormai quello di uniformare e irregimentare non creare individui liberi e responsabili: lavoratori ubbidienti, con scarso senso critico e ancor meno ideali...
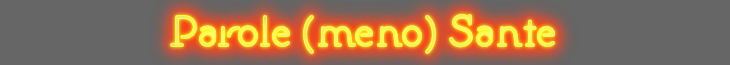









Trovo molto inquietante una scuola che si occupi dell'educazione. Mi sovvengono i peggiori scenari di distopie del Pensiero Unico della Suprema e Superiore Ortodossia.
RispondiEliminaRobe alla Pol Pot o woke.
È bene avere un ministero della istruzione e non della educazione.
In effetti ci che poi fece dire a Mussolini che è impossibile governare gli Italiani.
UUiC
Può darsi che qua e là abbia usato "educazione" invece che "istruzione". Forse lo stesso traduttore di Huxley ha sbagliato a tradurre il titolo del capitolo in oggetto "Educazione alla libertà".
EliminaMa qui rischiamo di fissarci sul dito invece che sulla Luna!
L'educazione/istruzione che auspicavo io è alla libertà e alla responsabilità: in pratica a opporsi al potere quando è giusto farlo. Tutte le dittature invece usano la forza della scuola per preparare studenti abituati a obbedire senza discutere, al culto dello Stato (o del dittatore di turno) infallibile.
Insomma chiamiamola pure "istruzione alla libertà" se lo trova più corretto ma ciò non cambia il senso di ciò che intendevo!